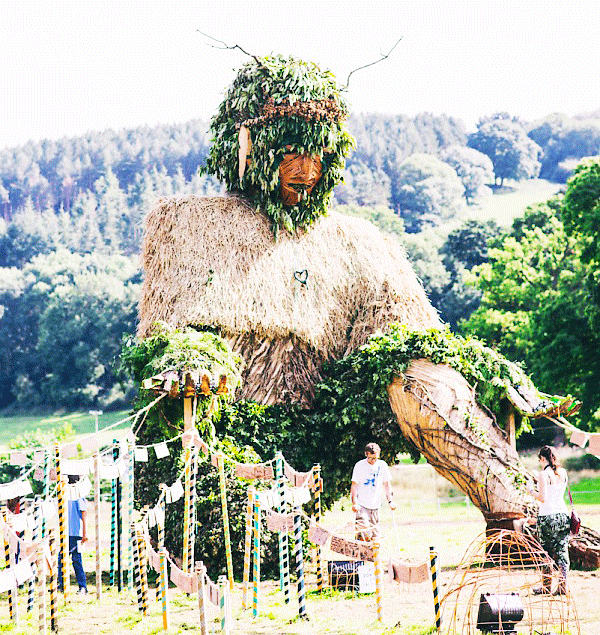
GREEN MAN FESTIVAL
20-23 agosto | Breacon Beacons | Galles
Ecco. Il sogno di chi scrive è uno e uno soltanto, neanche così impossibile a realizzarsi, in fondo in fondo (anche perché, a guardarsi un poco intorno i segnali incoraggianti non mancano affatto). Ma qual’è dunque il sogno? Ebbene, che anche nel (fu?) Bel Paese si possa un giorno avere un festival bello e vivo come il Green Man. Cresciuta senza fretta (ma a ritmo regolare) in fama e dimensioni in poco più di due lustri, oggi questa splendida manifestazione orgogliosamente gallese conta ogni anno qualcosa come ventimila visitatori in quattro giorni, per centinaia di concerti (da mezzogiorno alle due di notte) sparsi su cinque palchi, nel cuore verde pulsante di una vallata tutta fiumi, colline, casette nei boschi e pecore silenziose, che pare quasi uscita da una pagina del Bosco di Latte di Dylan Thomas e forse lo è davvero.
“Glocalizzazione” di un territorio che si apre al mondo restando a misura d’uomo, abbattimento morbido delle barriere generazionali (moltissime le famiglie con bimbi al seguito, ma anche gli adulti e gli “anziani” felicemente mescolati ai teenager, segno di grande civiltà), intimo rispetto per la natura e l’ambiente, filosofia pacificamente edonista e “slow” (innumerevoli gli stand e gli standini gastronomici delle più varie ispirazioni, senza contare un’area, animata a suon di workshop e seminari, con oltre cento tipologie di birra e sidro); sono queste le parole d’ordine di un festival che con sommo orgoglio ancor oggi vive per iniziativa di un gruppo di amici e famiglie “del posto” e che potremmo anche definire hippy, se solo non risultasse poi paradossalmente riduttivo nei confronti di un cartellone artistico che da anni brilla per il suo eclettismo non artefatto.
Il primo giorno, in larga parte dedicato alla sistemazione nell’attrezzatissimo campeggio, è per lo più consacrato all’elettronica, con Gwenno (la bionda gallese ex-Pipettes), Peter Broderick e Dan Deacon nel pomeriggio e i redivivi Leftfield ad animare le ultime ore del giorno, a suon di IDM sparata sotto il mega-tendone del Far Out (location deputata ad ospitare essenzialmente gli act più rock e psichedelici per poi trasformarsi in arena dance allo scoccare della mezzanotte). Dal venerdì si inizia subito a fare sul serio sul principale Mountain Stage con lo space-pop degli Hunck, londinesi vincitori del contest Green Man Rising 2015, da tenere d’occhio. Dopo di loro è un crescendo senza fine. Prima gli scozzesi C Duncan, ovvero la risposta di Glasgow ai Grizzly Bear: armonie corali da brividi lungo la schiena e arrangiamenti dream-folk senza macchia (consigliamo di recuperare il debutto Architect di quest’anno). Poi, in rapida sequenza, un ispiratissimo Bill Ryder-Jones che presenta in anteprima le tracce (che paiono onestamente tra le sue migliori) del nuovo West Kirby County Primary e una Natalie Prass a tratti irresistibile. Tra i due il piccolo eroe locale Sweet Baboo, nome d’arte di Stephen Black, arguto e spiritoso menestrello che, con la sua Walking In The Rain, fornirà l’involontario inno di un festival spesso sfiorato dalla carezza gentile di una pioggia soffice e leggera, fin troppo inglese, che cade senza mai alzare la voce. Nel frattempo al Walled Garden, palco ubicato per l’appunto in un delizioso giardino protetto da vecchie mura che in più d’una occasione utilizzeremo come provvidenziale sostegno per la nostra schiena stremata, il giovanissimo Declan McKenna delizia un pubblico sparuto con il suo indie-pop confidenziale e fai da te, del quale, c’è da giurarci, visti anche i recenti exploit di SOAK, sentiremo presto parlare. E se i Villagers ci ricordano ancora una volta che splendido disco sia il loro ultimo Darling Arithmetic, il noise-rock inutilmente tortuoso e dissonante dei Viet Cong ci conquista solo a tratti (molto meglio le detonazioni hard-pysch senza tregua degli impressionanti Hookworms). Un improvviso intensificarsi delle precipitazioni ci regala l’inusitato spettacolo di giovani inglesine tutte prese a ballare la loro improbabile danza della pioggia al ritmo caliente di una Maybe on Monday che i Calexico dirottano poi con mestiere verso una rilettura vibrante della sempreverde Alone Again Or. Al calar delle tenebre i Temples, dentro il buio costipato del Far Out, insidiano l’attuale baronaggio neo-psichedelico dei rivali Tame Impala, grazie ad un’anfetaminica esibizione degna del migliore Ufo Club, sinceramente sorprendente (eseguito anche un brano nuovo), che non lascia spazio ai vecchi scetticismi del sottoscritto ma giusto il tempo (scalette sempre rispettate al secondo) di tuffarsi a pesce nel collaudato greatest hits degli Hot Chip, al solito ordinati e precisi ma senza travolgere, come un orologio al quarzo che non salta un beat uno (curioso il finale con Dancing in The Dark del Boss a mandare tutti o quasi al letto).
Il sabato si apre sulle note della giovane promessa Anna B Savage – che, con un po’ di fortuna, potrebbe anche imporsi come la nuova Anna Calvi -, per poi trovare un primo approdo sicuro nello psych-pop venato di soul dei gallesi Colorama, degni della massima attenzione. Una pioggia battente permette di godere solo in parte dell’indie-lofi in odor di Vivian Girls delle Girl Ray al Rising Stage (palco riservato alle giovani promesse selezionate dal festival), così come delle trame futuristiche di Jane Weaver; il tendone del Far Out viene dunque preso d’assalto per i maliani Songhoy Blues (che confermano la gran sensazione suscitata dandoci dentro eccome) e l’unico rifugio in attesa che spiova si rivela essere una birra spillata e bevuta con tutta calma all’asciutto, con gradevolissimo sottofondo a firma The Leisure Society. Non riusciamo a beccare nemmeno i secret guest Sexwitch (nuovo progetto di Bat For Lashes e Toy) ma dell’esibizione di Charles Bradley non un solo secondo viene perduto: sensuale e appassionato, il soulman newyorchese si produce impeccabilmente in uno show memorabile, che accende cuore e muscoli e anche qualcos’altro, ammiccando con fare al contempo solenne e sfrontato, sciogliendo erotismo e ispirazione divina in una superiore forma di santità fiammeggiante. I Television, in serata, si difendono con decoro, sciorinando le ormai leggendarie astrazioni chitarristiche di Marquee Moon, eppure i Fall poco dopo, a parità di autorevolezza storica, fanno valere tutta la differenza di peso specifico di un’avventura che, con più di trenta dischi in quarant’anni di fiera militanza, è ancor oggi viva e pulsante. Gli uomini dell’immarcescibile Mark E. Smith (che già nel pomeriggio aveva intrattenuto i fan nel talking shop organizzato dalla rivista Mojo, sparando freddure in un inglese pressoché inintelligibile) rovesciano senza pietà sul pubblico in visibilio una betoniera di garage krautedelico che esalta i sensi schiacciandoli in una morsa senza scampo. Tutto è pronto per il concerto-evento degli eroi nazionali Super Furry Animals, fermi dal 2009 e in vena di (auto)celebrazioni per via della ristampa potenziata dello storico Mwng (primo album in gaelico a far breccia nella top twenty inglese, mica bruscolini, giova ricordarlo). Il concerto di Gruff Rhys e compagni tuttavia non decolla mai davvero, perdendo lungo una scaletta per certi versi anche discutibile il filo di un’esibizione che si sarebbe voluta folle e delirante, sporcata invece da una resa sonora certo non ottimale (unica eccezione per un festival altrimenti sempre caratterizzato da suoni ai limiti dell’irrealtà). Ma l’ultima mano di giornata spetta per fortuna agli Slowdive, per nulla invecchiati, anzi: i pezzi di Souvlaki e Just For A Day sono in fondo solo il pretesto per lo scatenarsi di un’aurora boreale di implosioni shoegaze a fior di pelle e feedback mulinanti, da godere a capo chino fino all’ultima e più sottile rifrazione di suono.
Le poche energie residue della domenica vengono convogliate sui succulenti antipasti offerti da Martin Carr (ex-gloria brit pop alla guida dei Boo Ridleys) e dalla giovane e bravissima norvegese Aurora (recuperate il suo bel Running With The Wolves, dalle parti di Florence/Purity Ring). È poi la volta del godibilissimo revival riot grrrl di Waxahatchee (che non potremo qualche ora dopo confrontare con l’analoga arte di Courtney Barnett, causa tendone abbastanza sorprendentemente stracolmo). Segue lo shoegaze-pop molto introspettivo e ombroso degli Antlers che, attraverso un cortocircuito davvero paradossale, riporta per qualche tempo l’agognato sole sul festival: godibili e compatti, gli americani aprono la strada al folk trasognato delle Staves, i cui delicati idilli folk, a detta poi dello stesso interessato, costituiranno il miglior viatico allo show pirotecnico del grande Father John Misty. L’americano esegue i solidissimi brani di I Love You, Honeybear, cucinando il tutto con invidiabile presenza scenica e un ironico magnetismo da rockstar postmoderna: i suoni irradiano una luce semplicemente pazzesca, quasi fossero dipinti in tempo reale sulla superficie stessa dell’aria e il pubblico rimane letteralmente appeso alle labbra del songwriter di Washington per tutta l’ora scarsa del concerto. La bellissima St.Vincent, poco dopo, si presenta sul palco nella sua recenti vesti da diva techno-pop dalle movenze spiritosamente robotiche. Indossando un’aderente tutina nera che davvero minimi spazi concede all’immaginazione, la newyorchese si inerpica senza la minima difficoltà lungo le sofisticate e spesso oblique traiettorie del suo ultimo raffinatissimo lavoro in studio, ostentando una padronanza assoluta della scena che tradisce però talvolta un eccesso di calcolo teatrale. Tutto l’opposto dei Goat che chiudono il festival con il loro dionisiaco baccanale di psichedelia neo-pagana. Pura vertigine.
Quando infine, come ogni anno, il grande Green Man fatto di legno e foglie viene dato alle fiamme in un tripudio vistoso di fuochi d’artificio, la sensazione di aver preso parte ad un evento per più aspetti irripetibile si trasforma improvvisamente in sorridente certezza.
Francesco Giordani
