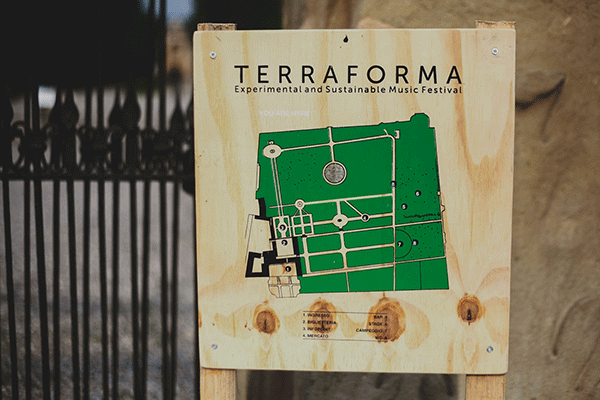
TERRAFORMA FESTIVAL
| Castellazzo di Bollate, Villa Arconati | 6-7-8 giugno
Riassumere in una pagina cosa sia stato Terraforma è impresa abbastanza facile, perché sarebbe sufficiente un elenco parziale degli artisti che vi hanno preso parte per rendere l’idea in maniera concisa e immediata. Più complesso è indagare su cosa sia stato Terraforma per l’Italia musicale e non, per la Milano che sul tema della sostenibilità ambientale sta già per compiere uno dei passi più falsi che si ricordino (ma questa è un’altra storia e non c’entra con la musica), per un luogo come Villa Arconati – sacro per gli abitanti delle abitazioni di Castellazzo che lo circondano, ma non abbastanza da meritarsi importanti lavori di ristrutturazione – e per un pubblico come quello nostrano ben poco abituato ad eventi di questo genere. Ma prima di tutto questo, Terraforma è stato il frutto di una grande e importante manifestazione di coraggio, necessario in dose ingente per scommettere sulla buona riuscita di un festival del genere in un paese che non aveva mai vissuto prima un’esperienza simile. La realizzazione di Terraforma è stato forse il vero, grande, autentico traguardo, più ancora della sua riuscita positiva.
A quest’ultima, più di ogni altra cosa, ci ha pensato la musica. Certo, il bellissimo giardino di Villa Arconati e l’invitante scenario del camping (che si sarebbe, volendo, potuto organizzare in una location più suggestiva e “immersiva” del prato centrale) hanno dato un contributo decisivo, ma il cartellone “coltivato” con fatica dai ragazzi di Threes e dai tanti collaboratori coinvolti ha funzionato in maniera perfetta. Un cartellone eterogeneo, il cui raggio è riassumibile forse solo con la definizione di “elettronica sperimentale”, talmente ampia da perdere fondamentalmente il suo senso. Perché se il Venerdì è stato il giorno del clubbing intelligente, quello in cui “si balla ma con le orecchie ben aperte”, il Sabato all-day-long è riuscito a conciliare avanguardia pura e dancefloor scorticati, mentre la chiusura soft della Domenica ha permesso di “tirare il fiato” riducendo l’impatto e aumentando la profondità. Un equilibrio perfetto e studiato, garantito anche dalla scelta di evitare una parade di nomi altisonanti per puntare su poche (e inusuali) punte di diamante alternate a nomi importanti appartenenti ad una dimensione più underground
Il racconto musicale dei tre giorni può esaurirsi in molte meno parole, perché per capire Terraforma è necessario esserci stati. La classica partenza col botto ha visto come primi protagonisti i Dalhous, freschi di debutto su Blackest Ever Black e autori di un bellissimo set da stazione spaziale nel cosmo fra bagliori armonici e tocchi alieni: a presentarli la benemerita rassegna S/V/N/, di cui si era già ampiamente parlato su queste pagine. Un’ora e mezza a cui seguono le altrettanto appaganti immersioni subacquee dei Voices From The Lake: Donato Dozzy e Neel inscenano il set perfetto per adattamento alla location, un brulicare di flussi liquidi, battiti sotterranei e folate, lasciandosi andare solo nel finale a qualche esondazione. Quanto basta per tracciare un ponte con Rabih Beani, in arte Morphosis, l’autentica sorpresa della serata: la sua techno altrettanto oscura e profonda domina fino a quando le poche barriere dell’inibizione si frantumano a suon di collage liberi. Che al libanese la free-form piacesse molto era dato già noto, ma stavolta l’approdo è ad un estremo talmente astratto da lasciare di stucco tutti i presenti, organizzatori compresi.
Stupefatto è anche Chris Madak alias Bee Mask, che conclude con un lungo viaggio nel suo personalissimo paradiso di suoni cristallini e e melodie limpide. Il modo migliore di accogliere le prime luci dell’alba di un Sabato che continua presto, dopo nemmeno sei ore di sonno, con Rawmance e la sua riversione in chiave marziale dell’acid-house. Un risveglio col botto a cui segue la più rilassata parentesi acustica alla chitarra di Norberto Lobo e un “pranzo” in compagnia di nientemeno che Ghédalia Tzartès, a parlare di musica concreta e della sua impromuz, la base su cui tutt’oggi poggiano le sue performance. Quando poi questi mostra sul pratico i processi spiegati, ne esce un’ora abbondante di contorsioni, droni roboanti, rumori assortiti e mutazioni vocali. Una passeggiata immersiva nella natura della villa conduce dritto ad un’altra interessantissima chiacchierata, quella con Pierre Bastien: l’argomento stavolta è proprio la natura nella musica attraverso elementi come acqua e vento, da sempre fonti di incredibile fascino e impiegati in più modalità di “far musica” e nelle prime forme di installazioni sonore
A chiudere il pomeriggio, prima che proprio Bastien si affacci al crepusscolo con le sue creazioni meccaniche, è Burnt Friedman che si porta da casa un paio di affascinanti macchine analogiche e le mette al centro del prato per poi sedervisi in mezzo e dar vita a un’ora e mezza di raffinato minimalismo sintetico. Chi colpisce nel segno più di tutti è Thomas Fehlmann, che apre la serata e nel frullatore mette di tutto tenendo l’enfasi melodica come comun denominatore e evitando di accelerare i bpm oltre la soglia del sogno. Pubblico in visibilio e caricato come nemmeno la sera prima, e a beneficiarne sono anche Millie & Andrea, ovvero Andy Stott e Miles Whittaker dei Demdike Stare, che si prodigano in una corsa impazzita nel fango, tra punte di memoria post-hardcore, divagazioni simil-dubstep e rientri in ranghi techno mai troppo definiti. Nella talk con Katie Gibbons di Wire avvenuta poco prima di cena avevano spiegato bene quanto il loro progetto fosse estraneo ai canoni delle rispettive esperienze.
Chiudono che l’una è passata da un pezzo e arriva infine Heatsick, famoso per presentarsi sul palco munito solo di una tastiera: il suo è di sicuro il set più dolce e ipnotico del cartello del giorno, una maniera inusuale e originale di concludere la nottata. La Domenica i tempi sono decisamente più dilatati e Native, l’uomo dietro Space Is The Place, offre una colazione a tinte tenui e spilli senza esaltare troppo. Per dare la giusta linfa al risveglio si deve aspettare James Blackshaw, che impugna la chitarra acustica e culla a suon del suo tipico fingerpicking, concentrandosi principalmente sui pezzi dei dischi più recenti. Nel primo pomeriggio la musica sembra diventare elemento secondario: è tempo di correre ad accaparrarsi le ultime disponibilità nell’area marketing, anche perché la house martellante a volume mite di Volcov non riesce a mantenere la carica magnetica che possiede su disco. Le cose cambiano all’arrivo dell’ultimo peso massimo, Scott Monteith aka Deadbeat, che lascia al mitico Mc Tikiman il ruolo di guidare all’interno dei suoi profondissimi affondi dub.
Il supergruppo allestito per chiudere la rassegna rappresenta però forse il vero apice artistico della stessa: Lorenzo Senni e i due Primitive Art, che hanno regalato un autentico congedo sfumato, ipnotizzando stavolta a base di scie luminose e paesaggi rarefatti, conducendo lentamente e delicatamente verso la fine di un viaggio indimenticabile. Un’esclusiva che è la ciliegina sulla torta per un evento che segna un punto di svolta nell’universo della musica dal vivo nostrana. Solo il tempo ci dirà se Terraforma sarà stato solo un bellissimo fuoco di paglia, o se la sua indiscutibile vittoria riuscirà a propagarsi dando vita a quelle solide basi che l’elettronica sperimentale attende da tempo di affondare in Italia, e alla diffusione di un nuovo modello di festival: tutte cose di cui abbiamo davvero un gran bisogno.
Matteo Meda
ph Michela Di Savino

